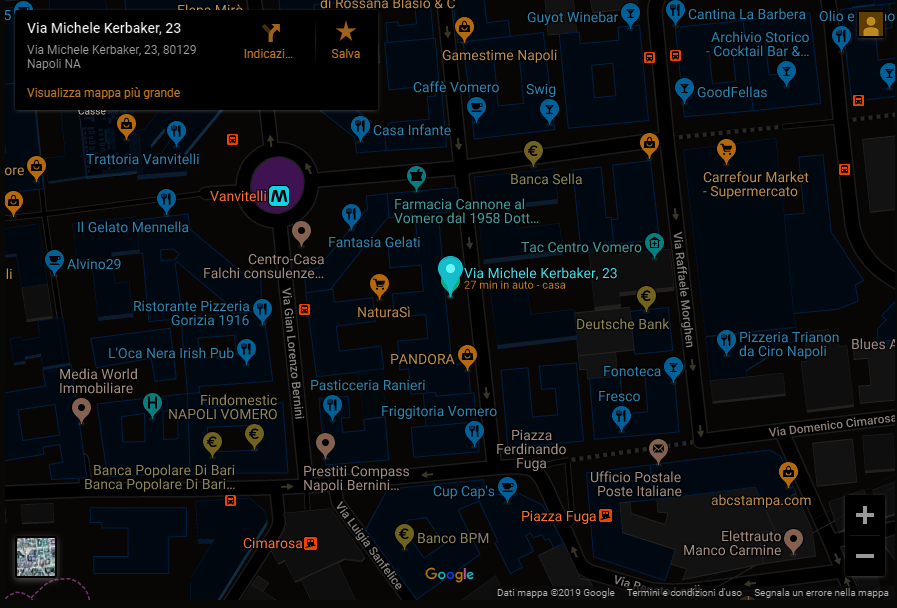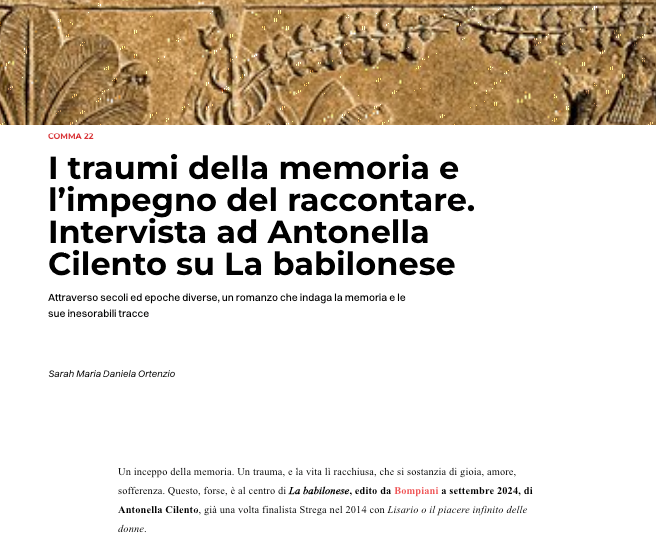
La rivista culturale online Limina ospita una lunga intervista di Sarah Maria Daniela Ortenzio ad Antonella Cilento sul suo nuovo romanzo, La babilonese (Bompiani). Questo l'inizio:
Un inceppo della memoria. Un trauma, e la vita lì racchiusa, che si sostanzia di gioia, amore, sofferenza. Questo, forse, è al centro di La babilonese, edito da Bompiani a settembre 2024, di Antonella Cilento, già una volta finalista Strega nel 2014 con Lisario o il piacere infinito delle donne.
Un romanzo d’amore e di vendetta, costruito su più piani, cerchi concentrici di epoche lontanissime, punteggiate dal medesimo fil rouge: dalla Ninive del VI secolo a.C. si approda all’Ottocento, poi alla Napoli seicentesca di Aniello Falcone, e ancora nell’Ottocento. Il romanzo culmina (o meglio, s’esaurisce) ai giorni nostri, dove il trauma si compie (forse) per l’ultima volta, nelle vite di Alice e Angelo, alle prese con il fallimento di un progetto imprenditoriale.
Raccontare un romanzo così ricco e generoso è difficile se non impossibile in questo spazio ristretto, sicché chiediamo alla stessa autrice di illustrarci la sua ultima straordinaria fatica.
Il trauma, l’inceppo della memoria, ha l’aspetto di una stanza bianca. La vediamo per la prima volta nel palazzo di re Assurbanipal, come spazio di morte, e invece nella Napoli del Duemila diventa la White Chamber, un’azienda di recupero dati. Qual è il legame tra le due cose? E perché proprio il colore bianco?
Diciamo che l’idea è partita da un dato reale: la clean room in cui si salvano i dati dai supporti danneggiati è effettivamente candida e disinfettata come una vera sala operatoria. L’ultima parte di La babilonese parte proprio dal fallimento di un’azienda che salva supporti danneggiati e qui la mia personale esperienza ha un peso: quando s’inaugurò l’azienda del mio compagno, rimasi piuttosto impressionata dalla stanza dove si entrava in tuta d’astronauta o come in un presidio ospedaliero. L’idea della White Chamber viene da lì. Ma bianchi erano anche gli ambienti dove era passata una pestilenza o una epidemia di qualunque genere: calcinare le pareti per disinfettarle è un’abitudine antichissima e diffusa in tutto il Mediterraneo, attiva anche nel 1656, l’anno della pestilenza napoletana di cui si narra nella terza parte di La babilonese. Infine, i luoghi dove avvenivano sacrifici o esecuzioni venivano spesso riattintati di bianco in antichità e da qui l’immaginazione di una stanza bianca anche nella ziggurat di Ninive dove sono uccise le quattro figlie della regina nella prima parte del romanzo. Sono luoghi dove si salva o si cancella, dove si vive o si muore. La perdita di tutto dopo il fallimento per Angelo e Alice nell’ultima sezione di La babilonese è un trauma definitivo, come una morte in vita, solo in apparenza meno grave della morte portata dalla violenza o dalla malattia. Quindi, una camera bianca c’è in ogni sezione, perfino nella Londra del 1848. Quando non vogliamo vedere un crimine, quando si vuol passare un frego sull’accaduto, quando si vuole dimenticare. La memoria che si salva nello stesso ambiente bianco in cui la si cancella mi ha a lungo ossessionato.